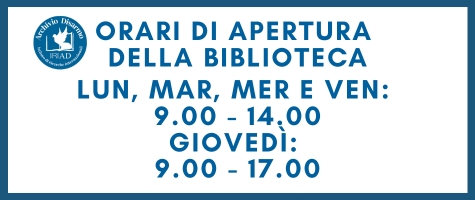L’immigrazione tra potenzialità e conflitti
Roma, 4 maggio 2015
L’immigrazione tra potenzialità e conflitti
A cura di F. Battistelli
Ciò cui assistiamo oggi tra le rive del Mediterraneo non è un semplice movimento migratorio, bensì una vera e propria trasmigrazione: dunque un processo ampio, impegnativo, di non facile gestione. Questo spostamento di masse è, secondo i demografi, in forte aumento. Di fronte a ciò che sta avvenendo, occorre porsi con piena consapevolezza per assumere le responsabilità che ci competono, operando ciascuno nel proprio ambito professionale e civile così da rendere questo evento di portata globale positivo e gestibile.
Negli ultimi tempi se ne discutono a fondo i pro e i contro. Gli stessi studiosi sono divisi tra chi guarda alle migrazioni con le lenti colorate, come ad esempio l’antropologo indiano-americano Arjun Appadurai, che descrive gli spostamenti globali di lavoratori, rifugiati e turisti come parte di una grande “etnorama”; o, invece, l’inglese Paul Collier che parla non di un movimento migratorio bensì di un “Esodo”. Inoltre, può accadere che all’analisi si sostituiscano dei veri e propri preconcetti di natura ideologica e politica dai quali occorre rifuggire dando priorità all’interpretazione rigorosa dei fenomeni, alla luce della quale sia possibile trarre eventualmente delle conclusioni. Condivisa la necessità di sostituire alla semplificazione mediatica e di senso comune una conoscenza scientifica e rigorosa, partiamo dai dati. Secondo l’ISTAT gli stranieri residenti in Italia oggi sono circa cinque milioni; per la precisione 4.922.000 nel 2014 rispetto ai 3.878.000 del 2011.
Nel passato le immigrazioni sono state attratte soprattutto da politiche del lavoro o di popolamento per chiamata (modello pull) come è avvenuto da parte di Stati Uniti, Argentina, Brasile, Australia, paesi che sollecitavano l’arrivo di forza lavoro in quanto necessaria per promuovere lo sviluppo economico. Oggi, invece, prevale una migrazione di spinta (modello push), cioè un processo determinato da fattori di espulsione connessi alle critiche condizioni dei paesi di origine, come ad esempio da quelli che si affacciano sul Mediterraneo. Sempre riguardo ai dati, nel 2014 sono arrivati in Italia solo via mare 153.000 immigrati richiedenti asilo. Essi cercano nel nostro paese una soluzione a problemi drammatici di sopravvivenza, provenendo spesso da aree di crisi dove vigono la guerra, il terrorismo, condizioni politiche e sociali disperate. Oltre ai migranti economici vi sono i rifugiati e richiedenti asilo. Nel 2014, il nostro Paese ha ricevuto 64.625 richieste di asilo, ponendosi al terzo posto tra i paesi dell’U.E. Nello stesso anno, quest’ultima ha ricevuto in totale 626.000 richieste, 191.000 in più rispetto al 2013 (+ 44%) (Eurostat). Esistono dunque aspetti di soccorso umanitario, di riconoscimento dei diritti umani, tutelati dalla Comunità Internazionale (Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951/Carta di Roma su impulso dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel 2008).
Sullo sfondo resta il problema di che cosa fare in una situazione di grande trasformazione come l’attuale, di fronte alla rivendicazione di soggetti i quali cercano lavoro, welfare, abitazione e riconoscimento dei diritti umani e civili che non trovano nei paesi di origine. Non si tratta di un fenomeno contingente, bensì un processo strutturale destinato a durare nel tempo. È chiaro che dal punto di vista qualitativo esso – come tutti i fenomeni umani – non è univoco, non può essere letto (come avviene invece in chiave mediatica) con criteri strumentali o riduttivi, per cui è visto o positivamente in “bianco” o negativamente in “nero”, con una larga prevalenza di quest’ultima modalità. Il fenomeno è complesso e richiede una visione multi-prospettica, in grado di evidenziare i punti di forza e i punti problematici dell’intera questione.
Nel primo caso le immigrazioni presentano indubbi aspetti positivi, in particolare in quelle società che – come quella occidentale in genere e italiana in particolare – stanno vivendo una transizione demografica caratterizzata dal 2009, dopo la lieve ripresa del periodo precedente, da un nuovo calo delle nascite. Attualmente siamo ben sotto la crescita zero, con un tasso di fecondità che nel 2013 è sceso a 1,29 per donna. Correlativamente, il nostro Paese presenta un tasso di invecchiamento della popolazione tra i più pronunciati d’Europa che, a sua volta, è il più elevato del mondo. La presenza di stranieri ha un effetto positivo dal punto di vista demografico, nel senso che la migrazione contribuisce, almeno in parte, a colmare i vuoti sia in numeri assoluti, sia come classi di età. Infatti è molto importante che nel paese vi sia un’adeguata quota di giovani i quali, oltre ad assicurare il ricambio generazionale, sono coloro che mantengono in piedi il sistema previdenziale, consentono cioè con le loro tasse il pagamento delle pensioni. Ancora, sul piano economico l’immigrazione contribuisce all’incremento del Prodotto Interno Lordo. Nel 2012 i contribuenti nati all’estero sono 3.5 milioni e hanno dichiarato redditi per 44,7 miliardi di euro pari al 5,6% dei redditi. Tra loro, gli imprenditori stranieri presentano un’attività pari all’8,2% del totale, che produrrebbe il 6,1% del valore aggiunto prodotto dalle imprese operanti in Italia (Fonte: Fondazione Leone Moressa, 2014). Secondo stime della stessa Fondazione, la ricchezza complessiva prodotta dagli occupati stranieri sarebbe di 123 miliardi di euro pari all’8,8 del PIL italiano.
Accanto a questo, ribadiamo che, con altrettanta razionalità ed equità, si devono affrontare tutti gli aspetti dei fenomeni che si analizzano. In questo caso, oltre agli aspetti positivi citati occorre rivolgere l’attenzione anche verso quelli problematici. A questi ultimi appartiene la capacità della società di assorbire e metabolizzare la presenza dei nuovi arrivati, i quali indubbiamente introducono nei nostri equilibri una varianza di natura sociale e culturale. Il tutto va rivisitato alla luce di due concetti che a una visione superficiale potrebbero sembrare solo negativi, ma che in realtà non lo sono. Si tratta della diversità e del conflitto che, a ben vedere, sono elementi incomprimibili e necessari della stessa condizione umana.
In tal senso un contributo istruttivo è stato offerto dal movimento delle donne. Il femminismo degli anni Sessanta e Settanta ha, a un certo punto, smesso di concentrarsi solo sul tema della parità – che comunque non è mai un obiettivo “troppo” acquisito per essere abbandonato – per porre l’attenzione sul tema della differenza. A cominciare da quella di genere, cioè uomo/donna, in cui ci si trova di fronte a una differenza che è un dato non solo biologico, bensì la sintesi di lasciti storicamente sedimentatisi in una situazione di dominio che oggi si ritiene intollerabile. Differenza vuol dire anche recuperare l’originalità, la specificità, la creatività di un soggetto – la donna – che si definisce a partire dall’oggettività dell’appartenenza del sesso per pervenire alla soggettività del genere. Su questo si innesca la dialettica, complessivamente positiva, che ha caratterizzato la relazione tra uomini e donne in questi ultimi trent’anni.
Quindi le differenze vanno riconosciute, perché disconoscerle non è un segno di progressismo o di illuminismo, tutt’altro. Da sempre chi sta in una posizione dominante tende ad ignorare le differenze. In narrazioni della letteratura popolare come Via col vento o La capanna dello zio Tom sono descritti i grandi proprietari terrieri del Sud degli Stati Uniti, i quali pensavano di non far pesare grandi differenze sui loro schiavi afroamericani. Infatti li tenevano in famiglia, li trattavano umanamente, sia che fosse lo zio Tom che abitava poco lontano dalla villa dei proprietari o la Mamy che cucinava e allevava i figli dei signori: quindi non si capiva il perché di certi fermenti, venuti dal Nord a portare dannosi sconvolgimenti sociali. Non vedere le differenze se non è un abbaglio è un inganno, ovvero qualche cosa che, volontariamente o meno, ostacola la soluzione dei problemi. Quindi la prima cosa da fare consiste nel riconoscere le differenze. In questo momento abbiamo degli ingressi di persone che, ovviamente, sono in tutto e per tutto identici a noi in quanto titolari dei diritti propri degli esseri umani, ma con delle specificità che devono essere ri/conosciute.
C’è oggi a casa nostra la presenza di musulmani, cioè di persone portatrici di un’altra religione che vanno riconosciute innanzitutto come individui e poi come portatori di una propria cultura. La presenza di allievi islamici a scuola impone da parte dei docenti una formazione legata alla conoscenza dell’Islam, o meglio dei vari Islam, conseguendo la competenza che permette di colloquiare con i nuovi allievi sulla base di precise cognizioni di natura religiosa, storica, filosofica, culturale. Ragionare sulle caratteristiche distintive degli altri non ci esime dal riflettere su quelle nostre, in tutti i loro aspetti, senza complessi né di superiorità né di inferiorità. In questo ambito un’ulteriore sede sarà rappresentata, oltre alle materie esistenti, dalla “Educazione alla cittadinanza” che sperabilmente verrà introdotta al posto della vecchia Educazione civica.
Occorre lasciarsi alle spalle la superficialità del dibattito televisivo di questi ultimi anni, nel quale dominano due posizioni aberranti. Da un lato c’è un cripto-razzismo di marca politica che si ispira a miti assurdi e inconsistenti come quelli della razza. Abbiamo dovuto ascoltare affermazioni addirittura sull’esistenza di una “razza padana”, in palese contrasto con qualsiasi evidenza scientifica. Come se non bastasse, gli studi degli antropologi naturali dimostrano che tutti noi italiani (compresi ovviamente i “padani”) siamo un crocevia di etnie, con un patrimonio di geni che è considerato il più variegato d’Europa. Dall’altro lato, va superato un certo buonismo di maniera. Hegel nella Fenomenologia dello spirito parlava di “anime belle”, cioè persone che generalizzano gratuitamente sorvolando sul peso dell’essere. È chiaro che a scuola, a contatto con soggetti in età evolutiva per i quali le differenze non necessariamente sono un problema – ma sicuramente sono una caratteristica costitutiva – non c’è certo bisogno di acuire il conflitto. Tuttavia non è nemmeno giusto sottovalutare le divergenze di gusti, di opinioni, di propensioni, annacquando tutto nel girotondo di bambini con la pelle di vario colore che si stringono la mano tra loro. In campo educativo è importante che la pace, cioè la composizione consapevole delle differenze, sia un punto di arrivo e non uno stato scontato alla partenza.
Per fare questo occorre guardare con molta laicità ai fenomeni di cui siamo spettatori, di cui siamo protagonisti. In Italia la scuola è un protagonista di prim’ordine visto che, accogliendo nelle sue aule 802.785 alunni stranieri di prima e seconda generazione, pari al 9% del totale (10% nella scuola dell’obbligo) sta dando vita ad un’esperienza di successo nell’integrazione. Ci sono due sistemi organizzativi pubblici che, in barba a certa retorica mediatica, funzionano: sono la scuola e la sanità. Il sistema sanitario nazionale ha avuto un importante ruolo di accoglienza e di integrazione nei confronti degli immigrati attraverso la prestazione dell’assistenza per la tutela della salute, fornita universalmente a tutti coloro che ne hanno bisogno. Sette anni fa in uno dei due rami del parlamento, fu introdotto, per fortuna per pochi giorni, uno sciagurato emendamento che chiamava i medici a denunciare i pazienti che non fossero in regola con le norme in materia di cittadinanza. Questo provocò una alzata di scudi negli ospedali italiani da parte dei medici: caso emblematico di una professionalità universale che si ribella al legislatore che non sta esprimendo, come invece dovrebbe, la volontà generale. Gli addetti alla sanità hanno impedito così che una norma incostituzionale negasse, con il suo carattere repressivo e discriminatorio, l’adesione della Repubblica italiana ai principi internazionali che tutelano i diritti umani. Oggi in Italia il cittadino straniero può essere curato grazie a quella “invenzione” dal basso che è il tesserino STP, ovvero “Straniero Temporaneamente Presente”, in base alla quale, declinando o meno il proprio nome, egli semplicemente dichiara di non poter accedere alle cure private. Soluzioni come queste nella sanità e nella scuola hanno avuto esiti positivi nella gestione dei processi migratori nel nostro paese.
Detto questo, restano tuttavia delle questioni aperte, serie, che meritano una riflessione e che non hanno una risposta univoca. In realtà nella nostra professione di educatori il compito non è tanto quello di dare risposte, quanto piuttosto quello di illustrare i problemi, presentare delle analisi, e di suscitare domande, interrogativi che devono portare a soluzioni collettive e partecipate. Le analisi devono essere fattuali e insieme rigorose sul piano logico ed empirico, concrete e non astratte in quanto devono partire da ciò che stiamo vivendo nella realtà di tutti i giorni.
È d’obbligo fare un riferimento all’attentato di Parigi, un evento che ha rappresentato un trauma per tutti, innanzitutto per i francesi. Essi pensavano di aver messo a punto un sistema di gestione delle differenze il più universalistico che esiste, quello della democrazia repubblicana, figlia dell’illuminismo e della Rivoluzione francese, che prescrive pari diritti e pari doveri per tutti. Può essere stato un limite quello di enfatizzare l’uguaglianza e di sottovalutare le differenze, non prendere in considerazione le specificità di un gruppo culturale, quello islamico, la cui presenza può pesare sui valori e sui comportamenti di una società; il tutto senza che ciò possa essere ignorato o cancellato con un tratto di penna, sia pure ad opera di un giornale satirico. La questione era emersa in Francia già qualche anno fa in occasione della controversia del velo, rispetto al diritto di indossarlo per adempire una norma religiosa in contrasto con i dettami di una scuola pubblica di ispirazione totalmente laica. La questione è molto di principio, sul piano pratico prescrizioni così sono troppo rigide. Pure, questa è la prospettiva di un paese che ha una tradizione antica in tema di immigrazione. I governi francesi hanno cominciato a promuovere politiche migratorie nel 1871, per cui esistono quasi 150 anni di esperienza in questo campo. La motivazione iniziale era di carattere demografico, non tuttavia a fini economici quanto prevalentemente strategici, all’interno della sfida storica tra Francia e Germania. Per questo la Francia accoglieva italiani, spagnoli, portoghesi, immigrati culturalmente affini; eppure l’accoglienza non è stata priva di problemi, si pensi a eventi tragici che hanno avuto per vittime italiani immigrati in Francia tra 800 e 900. La Francia ha sempre fatto propri i valori universali della libertà e dell’uguaglianza; il dubbio è se, e come, è riuscita, effettivamente a realizzarli. Dichiarare la parità di fronte alla legge è sufficiente, quando poi nella realtà c’è un netto divario, ad esempio nel mercato del lavoro, tra le opportunità di un giovane francese e quella di un giovane musulmano delle banlieue?
Di fronte all’aggressione terroristica contro Charlie Hebdo, tutti noi abbiamo provato un forte disagio nel sapere che un giornale satirico (non leggero nei confronti di nessuno), ha subìto un attacco feroce da un commando islamista, che a colpi di arma da fuoco ha provocato una strage. Di fronte a un evento che ha scioccato tutti, la prima reazione è stata quella di rispondere: “Je suis Charlie!”. Se la prima reazione è stata quella di condividere lo slogan dei tanti francesi scesi nelle piazze, è altrettanto vero che, via via che le ore e i giorni passavano, la situazione è emersa in tutta la sua complessità. L’attacco dei terroristi resta inammissibile, ovviamente, tuttavia occorre riconoscere nei fatti certe discontinuità che impongono una discontinuità anche nelle interpretazioni. Per esempio non tutti i francesi hanno aderito alle manifestazioni di quei giorni e alcuni studenti di origine araba hanno dichiarato “Je ne suis pas Charlie!”, prendendo le distanze da una posizione che all’inizio sembrava condivisa da tutti. Se questo fa riflettere, ancora di più fa riflettere la presa di distanza da parte di settori dell’occidente, certamente non filo-islamisti e neppure periferici, visto che provengono dagli Stati Uniti. Poco dopo l’attentato, nientemeno che il New York Times ha espresso le sue riserve sull’incondizionato diritto di satira professato in Francia. Un paese come gli Usa, nato storicamente da un patto tra popolazioni di diversa composizione etnica, nazionale, religiosa, con lingue e culture diverse (anche con problemi irrisolti, come attestano gli ultimi disordini di fronte alle violenze della polizia contro gli afroamericani) ha tuttavia scelto la via del rispetto delle differenze e dei convincimenti dell’altro, come legge non scritta ma interiorizzata da ogni cittadino americano. Nei murales o nei muri di periferie immense e spesso degradate non troverete mai – come invece altrove – scritte razziste, grazie al tacito accordo che in America proibisce di toccare pubblicamente il tema della razza e quello della religione. Dunque siamo di fronte a un altro tipo atteggiamento, una variante pienamente occidentale dell’atteggiamento da tenere nei confronti dei valori degli altri.
In questa prospettiva è anche da ricordare la posizione di Papa Francesco, che ha messo in discussione la satira del giornale francese, quando ha affermato che se qualcuno osasse toccare sua madre lui risponderebbe con un pugno. Si tratta di una presa di posizione molto impegnativa da parte del massimo interprete di una religione basata sull’amore, si pensi al discorso della Montagna dedicata alle beatitudini, al rimprovero di Gesù a Pietro che nell’orto degli ulivi vorrebbe difenderlo con una spada ecc. Allora come mai il papa ha formulato un’affermazione così spericolata sul piano teologico? È chiaro che dietro ad essa non c’è improvvisazione; c’è piuttosto un ragionamento a tutto campo sulla tutela dei valori religiosi, in particolare delle minoranze che – in quanto tali – non possono essere additate, provocate e ancor peggio perseguitate. Il Papa è il referente di una religione che, pur essendo complessivamente la più seguìta sulla terra, in varie aree di essa è professata da minoranze: si pensi alle minoranze cristiane in generale e cattoliche in particolare in Pakistan, in Siria, in Irak. In Irak la situazione è degenerata dopo l’intervento militare del 2003 e qui non si può non criticare l’intervento americano, i cui effetti son stati deleteri anche da questo punto di vista. Prima della guerra, in Irak si contava un milione circa di cristiani, oggi essi sono ridotti a 300.000 e sono in costante diminuzione. Questo è accaduto per effetto di scelte politiche sbagliate che hanno dato sostanza all’incubo (che per qualcuno è una strategia) dello scontro di civiltà. Inoltre i cristiani sono oggetto di persecuzione in Africa, in particolare in Nigeria. Tornando al Papa, Francesco ha mandato un messaggio complessivo all’interno e all’esterno di un Paese cattolico, sia pure tiepido come l’Italia. Al di là dell’occidente e della stessa Chiesa cattolica, ha proposto di riflettere sul confine tra il diritto di esprimersi – che per noi occidentali è insopprimibile – e il dovere di rispettare i valori degli altri, cominciando da quelli religiosi. Si tratta di rispettare una componente culturale e psicologica fortemente radicata nella persona del credente (ciò senza nulla dire nel merito della trascendenza, vissuta individualmente, o anche negata, secondo una libera scelta) che nessuno può andare a toccare in modo superficiale: anche chi non crede deve rispettare chi crede. Certe forme di libertà di immagine raggiunte in Occidente non sono condivisibili da parte di tutti. Le immagini di Charlie Hebdo sono spesso pesanti: il fatto che non lo siano solo con l’Islam non giustifica la gravità dell’offesa. Immagini del profeta Maometto, ma anche di Gesù, descritti in attività sessuali sono fortemente provocatorie e se, al limite, possono essere tollerate in società secolarizzate come le nostre, in cui la scelta religiosa è considerata un fatto privato, non è detto che lo siano in una realtà in cui la religione è un fatto pubblico e collettivo. La questione riguarda il tema dell’identità: è veramente necessario per la libertà di espressione fare ciò che ha fatto quell’artista svedese che ha scolpito un cane con quattro zampe, una coda e la testa del Profeta?
Si profilano quindi quesiti complessi, che richiedono riflessioni approfondite e che rinviano ad una sensibilità che è addirittura pre-giuridica, in quanto prima dell’ultima parola in materia rappresentata dalle leggi, esistono codici sociali che possono essere discussi ma non possono essere ignorati. Nella convivenza civile non c’è soltanto la norma di legge che impedisce di fare qualcosa, esiste anche l’opportunità sociale e relazionale che qualcosa venga o non venga fatta. Nella loro funzione gli educatori hanno il compito di coltivare questa sensibilità e soprattutto di alimentarla nei più giovani. Non vogliamo che venga introdotta alcuna legge che limiti la libertà di pensiero, comunque espressa, sotto il profilo del ragionamento così come della satira (ulteriore complicazione visto che per definizione la satira irride). Tuttavia è possibile adottare l’applicazione di un costume anglosassone che è l’autolimitazione (self restraint), in base al quale nessuno impedisce all’altro di rappresentare un determinato soggetto in modo spregevole, ma qualcosa entro la coscienza dell’altro fa scattare un deterrente più profondo della norma giuridica, rappresentato dalla sensibilità, dalla humanitas, che è comunque presente negli esseri umani. Si tratta di tornare alla coscienza di matrice kantiana (Critica della ragion pratica) che prescrive di "non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te". Evitare di deridere gratuitamente le differenze costitutive degli altri, come suggerisce il fair play anglosassone, può non essere la soluzione definitiva e valida per ogni cosa, in quanto ogni situazione richiede una risposta ad hoc, tuttavia sembra un buono spunto di riflessione a cui improntare i nostri comportamenti. Accanto a questo, e subito dopo, si delinea il ruolo dell’ordinamento giuridico, che entra in vigore quando non è applicato il fair play. E’ fondamentale ricostruire nel nostro Paese il senso della legalità che si è molto affievolito in questi ultimi vent’anni. Occorre rivitalizzare un’adesione non formale, non ipocrita alle norme. Su questo si apre una questione molto importante: il rispetto delle norme richiede infatti un’adesione interiore che va insegnata ai nostri studenti, compresi naturalmente gli studenti appartenenti alle minoranze.
Quindi, per concludere, noi non dobbiamo avere paura del rispetto delle differenze, ma anzi esprimere il nostro ottimismo verso le differenze come fonte di mutamento e di arricchimento, che non esclude la chiarezza in ordine ad alcuni punti fermi. Che, ad esempio, nel nostro paese alcuni comportamenti non sono tollerabili, perché per la legge sono reati. Quindi il mio interesse di scienziato sociale verso le differenze culturali non arriva fino al punto di legittimare determinate pratiche che, vigenti in alcuni contesti, tuttavia possono essere disfunzionali in genere e certamente lo sono in un altro contesto, ad esempio nel nostro. Con tutta la possibile apertura, in Italia come nella totalità di paesi occidentali, noi non possiamo ammettere la poligamia. Questo è un punto fermo, per cui nelle forme dovute dovranno intervenire, se necessario, la magistratura e la polizia; resta il fatto che anche l’insegnante, pur rispettando il soggetto che fa parte di una cultura “altra”, ha il compito di sottolineare che nell’ordinamento vigente in Italia un uomo non può prendere più mogli contemporaneamente. Per simili e ancora più complesse problematiche si pensi alle mutilazioni genitali femminili. Si tratta di un fenomeno drammatico, sottotraccia e sottostimato perché molto difficile da individuare e da affrontare. Tuttavia alcuni sanitari coraggiosi hanno preso posizione, come ad esempio a Firenze il dottor Omar Abdulcadi, un medico di origine somala il quale ha introdotto campagne di prevenzione informativa allo scopo di far recedere le famiglie da queste pratiche. Che gli esseri umani confidino nelle tradizioni è ammissibile ma non significa che siano ammissibili tutte queste pratiche, comprese, quelle violente, se no avremmo il paradosso di avallare il cannibalismo o il rimpicciolimento delle teste.
Ciò non significa sminuire il fardello storico di molti genocidi che reca su di sé l’occidente. Si pensi a quando le guerre di religione le facevamo noi. Basta ricordare per tutte la notte di San Bartolomeo quando, nel 1572 in Francia, furono trucidati almeno 5.000 ugonotti per mano dei cattolici. E non parliamo solo di eventi di cinque secoli fa, dato che analogie nella logica, se non nella proporzioni, si sono perpetuate nel tempo: si pensi alla strage di cattolici irlandesi a Derry nella "domenica di sangue" del 1972. Quindi noi europei abbiamo alle spalle una storia che ci costringe a capire e a riflettere per evitare di ripetere gli stessi errori del passato, lontano e recente. È così che la maggioranza di noi concorda che non è giusto esportare la democrazia con la forza: i cambi di regime determinati nell’ultimo decennio dall’intervento militare di americani e alleati si sono rivelati un disastro politico e strategico, dall’Afghanistan all’Iraq alla Libia, compreso l’atteggiamento oscillante sulla Siria. Non si cambia l’assetto dei paesi con la forza, si dà invece il tempo necessario per maturare al loro interno una rappresentazione di se stessi (sociale) e una rappresentanza (politica), differenti magari dalle nostre ma tali da sviluppare autonomamente le capacità di cui sono dotati. Non si possono destituire i regimi per la pur grave ragione che sono antidemocratici, o peggio con il pretesto che detengono le armi di distruzione di massa. La menzogna che in proposito Bush ha indotto l’onesto segretario di stato Powell a pronunciare di fronte all’Assemblea delle Nazioni Unite è una delle più brutte pagine dell’occidente contemporaneo.
Detto questo, occorre sottolineare in che modo abbiamo superato le nostre guerre di religione, cioè grazie alla riflessione collettiva su 150 anni di atrocità “religiose” in Europa. Già nel Leviatano di Hobbes era contenuta la rinuncia degli individui alla facoltà di uccidere. Con la pace di Augusta del 1555 si è ratificata la rinuncia delle chiese – cattolici contro luterani – a imporre la propria religione agli altri; con il principio “cuius regio eius religio” chi non è d’accordo con la religione professata dal sovrano cambia regione. Certo siamo molto lontani da una vera tutela dei diritti umani, ma è comunque un passo verso una tregua che, con la pace di Vestfalia (1648), affermerà la pari dignità degli stati e l’avvio alla tolleranza religiosa per i sudditi prima e poi per i cittadini.
Quindi lasciamo ai paesi non occidentali di decidere la loro sorte, naturalmente cooperando con loro per la democrazia e per lo sviluppo. Quando però gli “altri” sono “da noi”, essi non possono esimersi dal rispettare le nostre leggi. Il fatto che le leggi vadano rispettate non significa che siamo immutabili, al contrario esse sono sempre soggette a revisione secondo le procedure legislative della democrazia. In questi anni abbiamo rivisto la legge Bossi-Fini, modificato il “pacchetto sicurezza”, fatto pulizia di norme incostituzionali (come il potere attribuito ai sindaci di emanare ordinanze in tema di sicurezza); mentre le leggi che riguardano il rispetto dei diritti umani non possono essere toccate. Ciò tuttavia non ci esonera dal contribuire a un patto con le popolazioni migranti fondato sul rispetto nei confronti dei loro valori, delle loro credenze, quando queste riguardano la coscienza. Quando invece i comportamenti interagiscono con altri cittadini o con le istituzioni pubbliche, le norme sono quelle del paese in cui l’immigrato decide di transitare o di stabilirsi. Questo lo afferma nel 1795 un grande filosofo che è anche un illuminato pacifista, Immanuel Kant. Egli rivendica per gli esseri umani sulla terra – che, essendo sferica non può interdire a priori nessuno spazio – il diritto di movimento per tutti; tutti hanno diritto di visita e nessuno ha diritto di trattare ostilmente lo straniero. Purché – scrive Kant nella sua Pace perpetua – “egli si comporti pacificamente”. Questo va insegnato ai nostri alunni, tanto autoctoni quanto provenienti da altri paesi. Su questo c’è una certa timidezza, un imbarazzo politico, magari perché si teme di dare spazio alle derive xenofobe e razziste di determinati partiti. Ma lasciare i nuovi arrivati soli di fronte alla questione dell’inclusione è fondamentalmente un errore, in quanto esso è un processo collettivo, che richiede le energie e lo sforzo comune di tutti.
In questo quadro credo che un tema importante sia il cambiamento delle coscienze di ognuno di noi. Nella grande manifestazione per Charlie Hebdo mi ha impressionato uno striscione degli studenti parigini che, rivolti ai terroristi, dicevano una cosa molto dura ma anche molto significativa: “Voi non ci cambierete”. “Voi non ci cambierete” è una frase che al momento mi aveva convinto. Ripensandoci, però, ho concluso che non può essere sottoscritta così com’è. Infatti non è possibile che lo stare accanto a un altro non ci cambi, perché l’incontro comunque cambia. Allora il messaggio andrebbe rivisitato così: “Voi non ci cambierete, se non cambierete voi stessi”. Insomma occorre riconoscere la reciprocità del mutamento che, a sua volta, non è un processo lineare né sequenziale, bensì circolare e ricorsivo, fatto di continui adattamenti in cerca di una dimensione condivisa. E’ un gioco di reciprocità nel quale non importa chi faccia il primo passo. O forse il primo passo va fatto da chi è in una posizione di privilegio: chi ha più risorse materiali ed immateriali può e deve fare il primo passo e porgere la mano alla differenza, nell’assunto che questa differenza voglia contemperare se stessa e dialogare. Un’utopia? Può darsi ma essa rappresenta, cronologicamente e moralmente, la prima scelta.
Per il resto ci sono le leggi dello Stato, in tutte le loro accezioni. Noi di Archivio Disarmo (IRIAD) siamo pacifisti; non assoluti, tuttavia, bensì relativi. Crediamo in una strategia dei piccoli passi e della reciprocità. Siamo per la gestione non violenta del conflitto, che di per sé giudichiamo positivo se non supera certe soglie e non degrada nello scontro più o meno armato, perché poi è soltanto distruttivo. Quando quella soglia viene superata, c’è qualcuno che se ne deve occupare. Noi siamo contro la violenza, contro lo sfruttamento, contro le ingiustizie; non siamo contro l’ordinamento giuridico, contro la polizia, contro la magistratura. Se qualcuno viola le leggi ne deve rispondere. Il nostro compito non è ostacolare l’individuazione e il contrasto dei reati, ma è quello di prevenirli, di formare i più giovani perché i reati non vengano commessi. La prevenzione non è una procedura tecnica, è una pratica sociale e culturale: questa mi sembra la via maestra per riconoscere gli altri e affinché gli altri riconoscano noi.